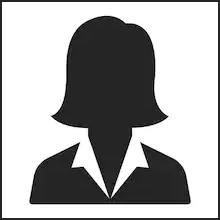Perché non ipotizzare una psicoterapia che abbia come obiettivo una profonda consapevolezza di sé e del nesso tra il proprio modo di stare al mondo (identità) ed i sintomi che la persona lamenta e lasci poi al suo lavorio autonomo, ai suoi valori, alla casualità degli accadimenti, troppo sottovalutata, e al mutare nelle varie stagioni della vita degli assetti motivazionali la scoperta di nuovi equilibri?
Il format della psicoterapia che abbiamo in testa è immutato da quando è stata formalizzata la psicoanalisi di Freud le cui regole costituiscono il “golden setting”, nato in una Vienna di fine ‘800 dove si andava in carrozza e c’era, oltre la sacher torte, anche l’imperatore Francesco Giuseppe; è rimasto pressoché stabile nonostante un paio di guerre mondiali, l’industrializzazione, la rivoluzione informatica, il web e soprattutto internet che ha reso accessibile a tutti moltissima informazione con cui da un lato bisogna necessariamente fare i conti rinunciando al ruolo di unici possessori e dispensatori per reinventarsi come novelli Virgilio che aiutano la navigazione, e dall’altro lato di cui ci si può avvalere rimandando ad essa e risparmiandoci un bel po’ di lavoro informativo (credo che tutto il mondo della psicoterapia sia colpevolmente in ritardo nella riflessione sul cambiamento attuale di cui libri come “The Game” di Baricco e la trilogia di Harari ”Sapiens”, “Homo deus”, “Lezioni per il XXI secolo” descrivono la portata e l’influenza su tutto il mondo della terapia) .
Per quanto riguarda invece la “mission” della psicoterapia e più in generale della psichiatria, si è se sempre cercato di conciliare due esigenze apparentemente contrastanti: da un lato il benessere soggettivo, e la libera espressione dell’individuo, dall’altro la protezione dei valori della società riconducendo alla normalità coloro che se ne discostavano creando scandalo prima ancora che pericolo. Quest’anima da “castigamatti” ci è immediatamente evidente in alcune società e regimi dittatoriali ma è presente sin dal primo “grande internamento” in cui gli ex lebbrosari trasformati in manicomi accoglievano ogni forma di devianza mentale, fisica, sessuale, culturale e politica custodendo il diverso affinchè non contagiasse il normale. E’ nel 1656 a Parigi che gli ex lebbrosari vengono trasformasti in Hopital General dove confluiscono lunatici, folli, eretici, criminali, libertini, puttane, soggetti con gravi malformazioni fisiche (mostri) e oppositori politici ( Michel Foucault 1963 “Storia della Follia nell’’età classica” ed. Rizzoli Milano).
E’, del resto, impossibile porsi al di fuori di una qualsivoglia cultura e quella in cui si è immersi fatalmente non la si riconosce. Non esiste attività umana che sia cultur-free, tanto meno la psichiatria e la psicoterapia. Si aggiunga che la cultura, pur influenzando ogni nostra espressione, lo fa senza che ce ne rendiamo conto. E’ potente proprio perché la diamo per scontata. Non è l’oggetto del discorso ma la sua premessa, la luce che illumina la scena non gli oggetti o l’azione che vi si svolge. La cultura modella al di fuori della consapevolezza i desideri e i criteri di giudizio.
Anche la psicoterapia ne è da un lato un prodotto diretto e recente (nemmeno 150 anni) e dall’altro un onesto servo idiota con l’aggravante di ritenersi intelligente. Se si escludono alcuni santoni che dichiaratamente vogliono insegnare ai propri pazienti come vivere trasformandoli in adepti, e poco conta che sia secondo i dettami del pensiero positivo, del razionalismo, dell’evoluzionismo o dell’etica evangelica della chiesa avventinzia del penultimo giorno, gli altri, diciamo così quelli seri (cui ci immaginiamo di appartenere), tentano di evitare questo rischio, e in tal senso possono persino essere più pericolosi perché inconsapevoli e poco evidenti.
Infatti per evitare il rischio GDQS (guru da quattro soldi) sono principalmente due gli argomenti e le strategie che si usano. Il primo è il cosiddetto atteggiamento “non giudicante”. Il secondo è il partire da una egodistonia del paziente fissando insieme a lui gli obiettivi. Credo che seppure vi si aspiri ciò si realizzi solo parzialmente e dunque non sia del tutto vero come la presunta ateoricità dei vari DSM (non è forse una premessa epistemologica fondante del cognitivismo–costruttivismo che non sono i fatti a costruire le teorie ma quest’ultime a organizzare e valutare i fatti stessi e dunque che sia impossibile prendere contatto con una realtà senza contemporaneamente valutarla e conoscerla attraverso schemi preesistenti ad essa?). Ma prendiamo momentaneamente per buono questo intento e diamolo per realizzato soffermandoci invece sulle premesse culturali implicite che esso stesso nasconde.
L’atteggiamento “non giudicante” tanto sbandierato non afferma in fondo con forza, per usare un ossimoro, un relativismo assoluto? per cui tutto va bene, tutto è ammissibile? Attenzione non sto affermando che questo sia sbagliato (peraltro è davvero la mia convinzione personale) dico solo che bisogna essere consapevoli che anch’essa è una premessa ideologica, non meno assoluta di tante altre e che non è l’unico modo possibile di stare al mondo.
L’egodistonia e l’autodeterminazione degli obiettivi mettono al centro di tutto l’individuo, il suo benessere e il conseguente diritto ad autodeterminarsi per ottenerlo che potremmo definire come “egocentrismo edonico”. Il messaggio che passa più o meno esplicitamente è “pensa a te, ai tuoi bisogni e desideri” (ricentramento su di sé) e “fai di tutto per realizzare il tuo benessere” (assertività) con l’unica attenzione a non essere guidato solo dal principio del piacere immediato ma di tener conto anche del principio di realtà e dunque anche delle prevedibili conseguenze relazionali del tuo comportamento ma sempre per perseguire un piacere che non sia solo a breve ma anche a medio e lungo termine.
Di nuovo mi astengo da qualsiasi giudizio in proposito, volendo limitarmi a suscitare consapevolezza che questo è un modello di uomo sano tipico della attuale cultura occidentale di matrice statunitense in cui ognuno deve darsi da fare al massimo per costruire il proprio personale benessere (tralascio la banalità che lo si pensa legato all’avere piuttosto che all’essere e raggiungibile piuttosto con il fare che con il sentire) in un ambiente di libero mercato del benessere dove il fatto che ognuno persegua il proprio comporta un miglioramento complessivo per tutti.
In tale clima di darwinismo sociale, l’agonismo per l’affermazione del più forte ha preso il nome molto più presentabile, su cui c’è grande consenso, di meritocrazia che non ha più oppositori essendo considerata appunto una ovvietà che turba alcune anime belle solo quando arriva all’eutanasia dei meno performanti o alla impresentabile eugenetica mengeliana di cui, però, è premessa. Ci vorrebbe un filosofo, uno storico e un sociologo per ragionare su questi temi. Mi basta qui sollevare un dubbio circa la presunta avolorialità della psicoterapia che a me sembra invece imbevuta di un egocentrismo edonistico che vede i legami con gli altri come strumenti di soddisfacimento dei propri bisogni. Esistono culture orientali costruite su altri valori che negano esplicitamente che questa sia la strada che conduce alla felicità ( basterà pensare alla millenaria tradizione buddista che oggi molte scuole psicoterapeutiche recuperano e riutilizzano ma in una cornice valoriale diversa).
Se il setting è una eredità soprattutto della psicoanalisi, l’idea di un cambiamento possibilmente rapido, evidente e misurabile proviene prevalentemente dall’approccio pragmatico del comportamentismo e del cognitivismo. Il fatto di ipotizzare un cambiamento non presuppone in fondo che ci sia un modo sano, corretto e giusto di vivere e che tutto ciò che vi si discosta sia patologico? E non è questo il ruolo normalizzatore, di controllo che, come detto ampiamente sopra, ha sempre costituito un’ambivalenza profonda della psichiatria, da un lato attenta a promuovere l’originalità individuale e dall’altra a mantenere l’ordine costituito su mandato sociale. Alcune grandi tradizioni psicoterapeutiche in particolare psicodinamiche si pongono soprattutto come un cammino di conoscenza di sé non mostrando quell’accanimento verso il sintomo, ne facendo quelle promesse di cambiamento a breve termine con le quali la psicoterapia cognitiva si è inizialmente accreditata forse per trovare uno spazio in un mercato già affollato.
Provo a immaginare una proposta finale a partire da 6 osservazioni
- Si potrebbe pensare una psicoterapia che per contratto si proponga esclusivamente di fornire consapevolezza sul proprio funzionamento lasciando poi eventuali cambiamenti al paziente che, grazie a tale consapevolezza, può reinventare nuovi adattamenti alla realtà che siano armonici con i suoi vincoli cognitivi, culturali e valoriali. La terapia potrebbe fermarsi al socratico “conosci te stesso” e poi fa ciò che vuoi.
- Potremmo considerare la vita di ciascuno con le sue scelte, le stranezze e anche le cosiddette “patologie” non soltanto come “quanto di meglio, poveretto!!, è riuscito a fare” ma come un modo unico e originale di stare nel suo mondo? Un modo quasi da salvaguardare come la biodiversità? (credo davvero che i vari disturbi di personalità soprattutto nelle forme non estreme siano un patrimonio genetico dell’umanità che ci consente potenzialità di adattamento ad ambienti diversi). Questo atteggiamento ridurrebbe lo stigma e i secondari di autosvalutazione caratteristici dei pazienti di ogni tipo.
- Probabilmente se esistessero medicine in grado di cambiare il modo di stare al mondo delle persone le guarderemmo con sospetto come una minaccia alla libertà e forse le metteremo fuori legge. Forse molti di noi rifiuterebbero di assumere un farmaco che ci liberasse dai sintomi fastidiosi ma al prezzo della nostra identità. Insomma siamo affezionati e orgogliosi del nostro essere noi stessi anche se comporta dei costi.
- Il disagio del vivere ha accompagnato da sempre l’esistenza umana, unica caratterizzata dalla consapevolezza della propria finitezza (dopo la cacciata dall’Eden per aver mangiato appunto il frutto dell’albero della conoscenza) e a tale disagio sono state cercate le soluzioni più varie che potremmo distinguere in due grandi categorie. Da un lato quelle “distrattive” miranti a ridurre tale dolorosa consapevolezza (come se fosse possibile rivomitare la mela) che vanno dall’impegno costante nel fare (poco importa se una famiglia, un figlio, una casa, un’azienda o un progetto per la fame nel mondo), all’uso di droghe (sostanze o fanatismi) che offuscano la mente. Dall’altro quelle opposte “concentrative” (consistenti nell’abbuffarsi di mele in tutte le forme) che puntano attraverso un ampliamento della stessa autoconsapevolezza a trovare la soluzione all’angoscia che essa stessa genera. Appartengono a questa categoria la filosofia, le religioni e le fedi a cui in periodi recenti della storia umana si sono affiancate con lo stesso scopo le ideologie. E’ come se si pensasse che gli animali gestiti dagli istinti nella loro inconsapevolezza vivano bene mentre l’uomo, consapevole e costretto a sapersi mortale, viva male e solo trasformandosi in un ipotetico superuomo che possa comprendere tutto, capire il come e il senso di ogni cosa possa nuovamente riconquistare la felicità e la libertà.
- Talvolta la relazione terapeutica somiglia a un tiro alla fune in cui il terapeuta punta al cambiamento e il paziente di contro con pari forza mira al mantenimento (resistenze) della propria identità (l’esempio estremo è il TSO in cui il paziente per il suo bene, che però è stabilito da qualcun altro, è privato della libertà di scegliere).
- A tutto questo si può obiettare che il più delle volte è il paziente stesso a chiedere aiuto perché i suoi sintomi sono egodistonici. Il fatto è che praticamente sempre il paziente è egodistonico sui sintomi ma per nulla sul modo di stare al mondo che li produce (vorrebbe eliminare i sintomi restando lo stesso, non cambiando nulla) ed è questo il motivo del successo dei farmaci che sono appunto richiesti perché ritenuti “sintomatici”.
Perché non ipotizzare una psicoterapia che abbia come obiettivo una profonda consapevolezza di sé e del nesso tra il proprio modo di stare al mondo (identità) ed i sintomi che la persona lamenta e lasci poi al suo lavorio autonomo, ai suoi valori, alla casualità degli accadimenti, troppo sottovalutata, e al mutare nelle varie stagioni della vita degli assetti motivazionali la scoperta di nuovi equilibri.
Per fare ciò il modello cognitivista “scopi/credenze” è particolarmente adatto perché corrispondente alle teorie psicologiche innate negli uomini. La psicoterapia si configurerebbe come una psicoeducazione sul funzionamento degli esseri umani in generale e poi in un’esplorazione sui propri specifici modi di stare al mondo (teorie psicologiche native, scopi, credenze, emozioni, strategie). In questo lavoro di esplorazione ci si può avvalere di ogni tecnica (test, osservazioni, sogni, meditazione, ipnosi, sostanze, ecc) che funzioni con quella specifica persona.
Una volta completato il lavoro di assessment che potrebbe risolversi in un paio di mesi al massimo di lavoro in seduta e con gli home work, il tutto sarebbe restituito e discusso con il paziente che potrebbe, qualora lo desideri, per suo conto fissarsi degli obiettivi di cambiamento da perseguire con i tempi e le modalità a lui più congeniali avvalendosi dei percorsi di auto aiuto e di apprendimento di specifiche skill che su internet e in libreria abbondano o degli strumenti disponibili nella sua cultura di riferimento (preghiera, meditazione, volontà, esercizi ecc.). Nulla esclude che il paziente ritorni a distanza di mesi o di anni a fare il punto con il suo terapeuta soprattutto nelle fasi di passaggi esistenziali.
Ho l’impressione che così il terapeuta si liberebbe dell’onnipotenza ma anche del peso di responsabilità che comporta e il paziente si riapproprierebbe della propria libertà e agentività e vivremmo così tutti più a lungo felici e contenti.
Molti criticheranno questa mia proposta accusandomi di essere “cicero pro domo mea” sapendo che se sono bravino nell’assessment, sono gravemente refrattario all’utilizzo delle tecniche che pure so essere efficaci. Il guaio è che hanno ragione.
Fonte: https://www.stateofmind.it/2019/07/psicoterapia-paziente/